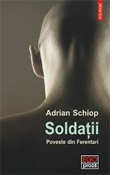|
|
Viaggio nella Bucarest reietta: «Soldații», il nuovo romanzo di Adrian Schiop
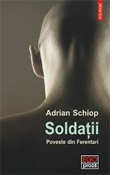 Con il nuovo romanzo di Adrian Schiop, intitolato Soldații – Poveste din Ferentari (Polirom 2013, 250 pp.), ci si imbarca per un viaggio in un mondo sconosciuto, in quel pianeta della Bucarest schivata, nascosta, reietta, pacchiana chiamato Ferentari, il quartiere-pianeta lontano in modo siderale dalla Bucarest rutilante, perbene e borghese che, esterrefatta, ci vive accanto, guardandolo dall’alto in basso. Con il nuovo romanzo di Adrian Schiop, intitolato Soldații – Poveste din Ferentari (Polirom 2013, 250 pp.), ci si imbarca per un viaggio in un mondo sconosciuto, in quel pianeta della Bucarest schivata, nascosta, reietta, pacchiana chiamato Ferentari, il quartiere-pianeta lontano in modo siderale dalla Bucarest rutilante, perbene e borghese che, esterrefatta, ci vive accanto, guardandolo dall’alto in basso.
Questo nuovo romanzo di Schiop ci scaraventa fin dalle prime pagine in una sorta di rito iniziatico, un rito che ci porta dentro una storia dove il confine tra finzione e autobiografia sembrano confondersi, la storia di un amore autentico, tenero ma improbabile – Adi, la voce narrante, ha una relazione quasi da esaurimento nervoso con lo scaltro ma sfortunato Alberto, un bambinone rom ludopata, extra-large e bisognoso di affetto, che ha trascorso quattordici dei suoi trentatré anni in carcere – la sua scuola di vita – dove, per le sue spietate leggi, era «assurto» a schiavetto sessuale dei suoi compagni di cella – una storia sincera e scioccante come sincero e scioccante è il modo con cui fluisce il filo narrativo tessuto dall’autore nel quale trasuda il più puro slang di periferia, preso direttamente dalla strada, dalle bocche dei suoi protagonisti: forse nessun altro romanzo romeno contemporaneo ce ne dà testimonianza con tanta varietà e immediatezza. E non si tratta solo della lingua, ma anche dei vari personaggi che animano la storia: non sembrano essere per nulla frutto della fantasia dell’autore, bensì prelevati di peso dalla loro realtà, dalle promiscue bettole e dalle strade apocalittiche di quella sorta di «buco nero», di zona «off-limits» di Bucarest che è il quartiere di Ferentari, scenario su cui si snoda la narrazione.
Adrian Schiop è un autore coraggioso, e in questo suo nuovo romanzo ci sbatte in faccia il lato meno ameno o più ributtante della realtà urbana della Bucarest marginale – e forse anche di se stesso –, ma non lo fa mai in modo gratuito o per il semplice gusto di apparire «provocatorio»; è soprattutto spudoratamente sincero come pochi altri, perché non gli importa misurare le parole, sente la necessità morale di non imbellettare ciò che lo e ci circonda o ciò che sente dentro di sé. Forse pecca di ingenuità, ma è proprio questo suo lato innocente e schietto che lo rende unico. È un atteggiamento che di sicuro lo rende sgradevole o perfino immorale agli occhi di alcuni, ma non si può negare che la sua scrittura abbia un carattere dirompente che ti colpisce allo stomaco come un pugno. Qualcuno potrebbe obiettare ad Adrian Schiop di voler esaltare e descrivere un ambiente e un linguaggio triviali, un mondo popolato da «boschetari» e «bulangii», da malavitosi e avanzi di galera, da tossicomani e alcolizzati, da figuri alla Gigi Becali, tutta una fauna umana confinata a un ristretto gruppo sociale, a una realtà emarginata, che vive per se stessa, che si regge su leggi proprie fuori da quella che è la società civile. Si direbbe inoltre che con questo romanzo Adrian Schiop attui fin in fondo la sua personale «crociata» contro l’idea secondo cui è riprovevole o inaccettabile toccare certi temi (vedi il fenomeno musicale delle «manele», oggetto di studio del dottorato che Adrian Schiop sta ultimando, e che nel libro rappresenta in qualche modo la colonna sonora – non a caso il libro si apre con alcune strofe estratte da una canzone di un «manelist» adolescente, Babi Minune –, temi insomma «periferici», scabrosi, ma che esistono e che in quanto tali non vanno elusi), crociata che è diretta quindi contro l’ipocrisia politicamente-finto-corretta della società intellettualmente impegnata e dall’allure «stîngista» – che Adrian Schiop svela all’interno del libro con efficacia e cognizione di causa – ma, allo stesso tempo, anche contro quella tabuizzata e arcaica della comunità rom urbanizzata. La storia omoerotica, pretesto e filo conduttore del libro, intreccia in maniera paradigmatica questi due mondi distantissimi fra loro facendone risaltare le reciproche contraddizioni, da cui si potrebbe dedurre che alla fin fine il nocciolo duro delle paure e dei tabù antropologici e collettivi accomuna il mondo emarginato e «balcanico» di Ferentari con quello del centro tutto «occidentale» di Bucarest. Le facce allibite – dell’una e dell’altra parte – di fronte a una coppia formata da un rom «abbronzato» e da un romeno «normale» o sospetto, per di più in eresia di «sodomia», sembrano non essere molto lontane da quelle orripilate alla vista di una coppia di un nero e una bianca (o viceversa) nell’America razzista degli anni ’50-60.
Non è quindi una storia strettamente gay né di rivendicazione omosessuale (cui l’autore non è interessato) – il filone gay è una tendenza editoriale che sembra tirare ultimamente in Romania (si veda anche il romanzo di Dora Pavel, presentato su «Orizzonti culturali» n. 11, novembre 2013, o il discutibile Cimitirul di Adrian Teleșpan) –, perché ovviamente le esplicite scene di sesso tra il narratore e Alberto, che qui abbondano, non trasformano in modo automatico questo libro in un romanzo gay (si ha la sensazione che qualche critico romeno ragioni invece proprio così): Soldații è gay nel senso inteso, pensato e vissuto da Adrian Schiop, senso che, come sempre in lui, rifugge da ogni schema e moda; è semmai la proiezione dei suoi fantasmi omoerotici e della sua storia personale, che non possono trovare «consostanzialità» nella realtà da cui è circondato, periferica o centrale che sia.
Non tutti o forse, più probabilmente, nessuno dei lettori gay che leggeranno questo libro vi si riconosceranno, ma di sicuro troveranno, come i lettori etero, una storia maledettamente buona.
In Romania il libro ha ricevuto l’unanime consenso della critica ed è stato fra i cinque libri della Polirom più venduti all’ultima fiera del libro «Gaudeamus». A riprova dell'ampio successo di pubblico, attualmente il romanzo ha già esaurito la prima tiratura e se ne sta approntando la ristampa dato che nelle librerie è introvabile. Che sia un buon momento per lo scrittore di Sibiu è anche confermato dalla notizia che Adrian Schiop ha ceduto i diritti del romanzo alla casa di produzione cinematografica di Cristi Mungiu in vista di un suo adattamento per il grande schermo, che si preannuncia assai interessante.
Invitiamo a leggere anche l’articolo su Adrian Schiop pubblicato nel n. 5 di «Orizzonti culturali» del maggio 2012.
Frammento da «Soldații – Poveste din Ferentari»
Balordi e ricchioni
La mattina gli ho detto i soldi son finiti Alberto, ti arrangi per le sigarette – e ha detto faccio un giro e me ne procuro qualcuna; mi chiamava ogni mezz’ora per dirmi sono qui davanti al laghetto di Cocioc; oppure sono al mercato di Progres e ho rimediato una sigaretta. E ho pensato amico, potrei fare la valigia in quattro e quattr’otto, prendere al volo due cose e svignarmela; infilo in tre sacchetti i miei stracci, chiamo un taxi e sparisco dalla scena – quando torna Alberto trova la casa vuota. Preso com’ero dal panico, questa alternativa era diventata molto reale, che cazzo faccio con questa catastrofe d’uomo? Pensavo febbrilmente, prendo questo e quello, fanculo i vestiti, quel che importa sono i documenti e l’apparecchiatura elettronica, di questa non devo dimenticarmi niente – al diavolo, gliela lascio così se la impegna, se la sbroglierà Alin a buttarlo fuori dall’appartamento, chiamerà la polizia, affare suo, è lui il proprietario.
Ma non ho fatto niente, il tempo è passato mettendo fine al mio piano d’evasione. Attorno alle 6 ha chiamato che stava tornando a casa, che non aveva più niente da fare in città senza soldi – e gli ho detto va bene Alberto, torna pure. Si è presentato con quattro sigarette, con i denti ha tolto il filtro da due e ne ha infilato la metà nelle altre. Ce le siamo steccate. Da mangiare in frigo erano rimaste solo alcune cosce di pollo rimaste per fare la minestra, le abbiamo cucinate e ha esclamato buonissime, mi piace rosicchiare, e alla fine si è detto sazio.
Il giorno dopo, attorno alle 12, quando Alberto era fuori a caccia di sigarette, mi ha chiamato al telefono Florică, puoi venire al bar da solo? È una faccenda legata a quel tuo farabutto. Ho chiesto quando dovevo andarci e lui mi ha detto adesso, ma vedi di portarti dietro un po’ di grana.
Quanto? Be’, foderati con almeno 50 lei.
Florică, ho piagnucolato, sono a secco, prima dovrei andare in città per chiederne in prestito, dài, facciamo dopo le 2; è seguita una pausa di mezzo minuto, dopo di che Florică ha detto va bene, facciamo alle 3, ma non fare tardi.
Ho chiesto in prestito cento lei – e quando sono tornato a Ferentari, Florică era seduto fuori a un tavolo con un tizio in tuta e ciabatte, e con gli occhi stralunati da alcolizzato.
Senti, Florică ci ha presentati, questo ha conosciuto in carcere il tuo amichetto. Io dico che c’avete qualcosa da dirvi, quindi, su, muovete il culo e andiamo dentro, in fondo alla sala, là non vi disturberà nessuno; a me offrimi un Alexandrion e al ragazzo una birra di suo gusto.
Piovigginava e tirava un vento freddo, ma dentro si stava al calduccio ed era pulito come dentro un nido; sulla parete di sinistra le luci al led dell’icona made in China con la Vergine Maria baluginavano silenziose in modo assurdo – assurdo perché associo mentalmente quella stanza all’inverno e al periodo festivo, alla stufa elettrica in un angolo, al plasma con il volume al minimo sintonizzato su Kanal D e a due, tre clienti che parlottano seduti a un tavolo.
Florică ci aveva già preparato un tavolo e, prima di uscire, ha detto al tizio raccontagli quello che hai raccontato anche a me, non gliela menare tanto. Dopo che se n’è andato, abbiamo brindato, mandato giù un sorso di birra e per un minuto o giù di lì, credo, è calato un silenzio imbarazzante, senza che ci guardassimo negli occhi.
Conosco il tuo amico dai tempi della galera, ha fatto il tizio rompendo il ghiaccio, hai della grana?
70 lei, è tutto quello che ho – e il tizio ha detto dammene 50. E quando gli ho allungato i soldi, ho notato che, sotto la barba rada, nascosta dalla pelle butterata, aveva una cicatrice, uno sbrego che gli attraversava la guancia sfatta terminando sullo zigomo.
Il tuo amichetto, ha cominciato, l’ha dato a tutti in galera.
Lo so, ho detto annuendo, mi ha raccontato che era il capoccia dei culattoni, il che gli ha reso la vita più dolce.
E lui si è messo a sghignazzare, capoccia dei culattoni? Forse era il loro babascione, perché Bilă era grande e grasso e la concorrenza se lo pappava in un sol boccone: infatti ce n’erano altri, di più giovani, e ricchioni sul serio, che sculettavano con talento, avresti giurato che erano delle battone – ma l’hai visto, sembra una maschiaccia, chi se lo poteva filare là dentro? Per due sigarette dava via il culo e faceva massaggi. Faceva lo spaccone quando diceva che era il cocco dei furbi, con te lo faccio a gratis che mi son affezionato a te, uno tosto e dritto come te non l’ho mai visto – ma chi se lo cagava, scusami, ‘sto cazzaro di un rotto in culo? Pussa via minchietta, dicevano, e gli appioppavano un cartone in testa. Ti sbavava dietro, dammi due sigarette e mi puoi fare quello che vuoi; ma i ganzi aho, e smamma, pezzo di merda, che ci fai ombra – e lo usavano per montare lo show, per infilarglielo quando si stufavano di girare i pollici.
E siccome gli sembrava che non capissi ha detto come te lo posso spiegare? Ci sono culattoni che ci sanno fare e poveri cristi come lui che passano per fessi, fanno ‘sta fine perché sono i ganzi a rincoglionirli. C’era un tipo, poveraccio, nel carcere di Poarta Albă, un pastore l’ha tolto alla madre quando era ancora piccolo per farlo suo schiavetto; lo ammazzava di botte e gliene ha date tante finché quello, poverino, è andato fuori di melone. Un giorno si è ubriacato e ha fatto fuori il padrone, fracassandogli il cranio con una mazza… Che cazzo può capire uno che passa dalle pecore al fresco? Che c’è gente come Becali e che il resto è una massa di coglioni. Questo, poverino, abbassava la testa come un cane bastonato e faceva tutto quello che volevi – e là dentro, in galera, se vedono che sei un fesso, ti mangiano in testa, ti mettono sotto a fare le troionerie più pazzesche, perché le giornate non passano mai e ai ragazzi gli piace prendere per il culo i fessi, così, per farsi due risate.
Vedi – ha continuato – non è che il tuo Bilă è come ‘sto poveraccio, si è scaltrito anche lui un po’ stando in galera – ma neppure lui ci stava con la testa fuori di casa. Lo schiavetto faceva la vacca da monta, abbassava la testa e stava zitto; il tuo invece ha imparato un po’ il mestiere in mezzo ai culattoni, gemeva, sculettava – oppure, quando i ganzi si rompevano il cazzo, faceva lo show; chissà, quando era più giovane, magari avrà avuto anche lui i suoi ragazzini da inculare – ma quando l’ho conosciuto io, i ganzi lo tenevano per montare lo show, lo usavano per fare le loro troionerie e con questo Bilă si guadagnava qualche sigaretta; per un paio di sigarette lasciava che i ganzi gli infilassero nel buco del culo il manico di una ramazza: uno se lo piazzava sul cazzo e Bilă se lo spingeva nel culo, così, sì, spingi, spingi, che godo come un riccio, quel cretino era un maestro in tutte le troionerie…
Tu non hai idea che succede là dentro, senza bottiglia ci può resistere anche l’ultimo degli ubriaconi che popolano le stazioni dei treni – ma senza sigarette, no, tu non hai idea cosa si è disposti a fare per una sigaretta. Una volta uno della cella gli ha messo un braccio attorno al collo e gli ha dato una bottiglia riempita con qualcosa di colorato che pareva cognac; gli ha detto se te la scoli tutta in un fiato, ti regaliamo un pacchetto di sigarette – altrimenti, sei fottuto; allora, Bilă, ci stai? E quell’allocco ci è cascato; ma invece di sputare il piscio, si è tracannato la bottiglia intera per avere il pacchetto di sigarette.
Questo faceva quando è finito in galera anche Borcan [cugino di Bilă]; quello aveva la grana ed è diventato subito il capo della cella – e quando ha visto quel che faceva suo cugino si è incazzato come una iena; lo ha riempito di botte, ha parlato con il secondino perché lo mettesse nella sua cella e ai ganzi gli ha detto di non spupazzarselo più dietro il paravento, che lui adesso era uno dei suoi. Bilă ha umiliato solo il ragazzo che gli aveva fatto bere il piscio, Borcan gli ha detto succhiaglielo qua davanti ai ragazzi; e poi gli ha detto con ingoio, cazzone.
Per il resto, Borcan era un tipo tranquillo e di poche parole, fatta eccezione per la faccenda con suo cugino, si faceva i cazzi suoi, se ne stava tutto il giorno davanti alla tv a smanettare col telecomando e si faceva fare i massaggi da Bilă. Si è dato una calmata anche Bilă perché Borcan lo riforniva di sigarette e divideva con lui i pacchetti che riceveva da casa. Basta guardarlo per capire che quel fesso è anche lui della teppa dei ganzi, per questo Borcan non l’ha più lasciato farsi cavalcare in galera perché metteva in ridicolo la famiglia… Dopo un anno, Bilă è uscito, mentre suo cugino è rimasto dentro, non so per quanto ancora perché sono stato rimesso in libertà anch’io.
Per tutto il tempo che abbiamo parlato, Florică è venuto al tavolo solo per prendere l’ordinazione – per il resto, è rimasto seduto fuori al tavolo in compagnia dei barboni. Alla fine mi ha alleggerito di cinque lei, era quello che gli spettava di mancia.
E dopo questa conversazione, mi è venuto un magone, ma un magone della madonna che ho cominciato a piangere mentre tornavo a casa: che è nato barbone e barbone morirà, per quanto meni i pugni e per quanto si dia arie da ganzo; che i 14 anni in mezzo agli untouchables, nella casta più infima della galera, quella dove t’infilano in culo un manico di scopa e succhi il cazzo altrui, lo hanno rammollito e reso docile del tutto; che è così ingenuo che nessuna donna se l’è voluto tra i piedi, tranne quella tarata mentale che bazzica alla stazione; il suo cervello è ridotto in poltiglia, fottuto dagli anni passati in prigione e si calma solo quando si mette a fare cose compulsive, come quei minorati che fanno su e giù con la testa nelle comunità d’accoglimento, stando dieci ore attaccato alle macchinette mangiasoldi o alla tv sintonizzato su Taraf, dove l’hit del giorno viene ripetuta ogni quarto d’ora.
E ho capito con tristezza che non me la potevo svignare alla chetichella perché da solo non se la poteva cavare, e fra me e lui si è tessuta ormai una ragnatela di attenzioni reciproche, impossibile da sgrovigliare da un giorno all’altro, questa faccenda mi avrebbe roso il cervello come un tarlo fino a bucarmelo: sono stato io a offrirgli una situazione stabile, con lui ho appagato tutti i miei capricci, e una volta stancatomi, l’ho buttato in mezzo alla strada; perché, così come dicono i carcerati, così come dicono i filosofi, nel mondo contano i fatti ed è per questo motivo che non ci si può sottrarre… Non me la sentivo di agire in quel modo, così come un genitore non può essere talmente disperato da comprare un gelato al figlioletto in stazione, dirgli di aspettarlo cinque minuti lì accanto ai bagagli – e poi sparire per sempre.
Be’, mi son chiesto, se non riesco a farlo, che cazzo mi resta da fare allora? – e ho fatto quello che sapevo fare meglio, darmi una nuova dilazione chiedendo in prestito altri soldi.
Ho chiamato il tipo che abita vicino a Bucarest e gli ho raccontato una palla, cioè che da un ladruncolo di quartiere avevo trovato un Samsung Galaxy a soli 600 lei. Capitava ogni tanto che ci prestassimo dei soldi, lui me li chiedeva quando i suoi erano in giro a mendicare, e io quando tardavano ad arrivare i soldi della borsa. Gli ho detto me ne servono 400 e lui mi ha risposto se è urgente te ne posso dare solo 250 e io ho detto vanno bene anche quelli, vai in banca e mettimeli nel conto; e lui mi ha risposto solo domani mattina, e io ho detto fanculo, dài, va bene lo stesso anche domani mattina.
Fino a quel momento avevo sette lei esatti, di cui due in monetine da 50 bani. Sette lei equivalgono a due birre da Boieru e sono andato dritto filato da Florică perché mi tirasse su il morale.
Da qualche ora era tornato il sereno e c’era un bel sole che faceva sollevare nuvole di vapore dalle pozzanghere piene di mozziconi e di cartacce; sotto il tendone azzurro del bar, la calura si era fatta soffocante, come dentro una serra umida.
Florică mi ha accolto trionfalmente – hai capito che razza di farabutto è il tuo amico?
Mi sono seduto vicino all’apparecchio dell’aria condizionata; faceva un giro di 180 gradi e, durante un minuto, mi inondava le braccia e il viso con un getto d’aria fredda.
Ho detto che farabutto, poveraccio, ha avuto un culo così se suo cugino l’ha tirato via dalla strada, sennò diventava un barbone. Si è attaccato a me perché mi credeva uno forte e pieno di soldi. Quindi, caro Florică, non me la sento di cacciarlo via, buttandolo in mezzo alla strada, perché suo cugino non se lo prende più in casa, e per colpa mia ritorna in strada e finisce male.
È per questo che ti sta tanto a cuore? ha detto Florică avvicinandosi una sedia al mio tavolo. Ma non ti ha già scroccato soldi a sufficienza?
E poi, visto che continuavo scuotere la testa abbacchiato dicendo che Borcan non lo avrebbe ripreso con lui, ha detto ma no, lo farà, è della loro gente e il sangue non è acqua.
Florică aveva un ottimismo a prova di bomba – questo andava bene, ma non sempre è utile; dovevi pensarci su due volte quanto avrebbe funzionato e la gente si girava ascoltando quello che stava raccontando.
Se vuole riprenderselo, ho pensato esitando, quello aveva il mio numero di telefono, perché Alberto l’aveva chiamato dal mio telefonino e il numero è rimasto nella memoria del suo cellulare. Magari era pure contento di esserselo tolto dai piedi, era una bocca in meno a casa da sfamare.
Ha mandato giù un sorso di cognac, se ne stava lì riflettendo – e alla fine ha detto io dico di no, qua la gente crede che fai il giornalista; quello vive mantenuto da una puttana e se ne sta nascosto, non ha certo bisogno di conoscere qualche giornalista. Fra l’altro tu porti qua anche qualche straniero, gente conosciuta, e quel ganzo non sa chi hai alle spalle, chi sei.
(…)
E la mattina, dopo aver prelevato i soldi, ho detto ad Alberto questi sono gli ultimi che mi sono fatto prestare, non so più dove andare a pescarli amico, c’è Crisi e ho già debiti per 1300 lei. Siamo andati insieme al mercato di piazza Progres e abbiamo fatto provviste come in previsione di un inverno nucleare, spendendo un cento lei per verdura, carne, formaggio, caffè.
Per un paio di giorni siamo rimasti tutti e due a casa – il primo giorno l’ho spedito fuori provvisto di sigarette e con dieci lei da spendere, ma, dopo mezz’ora, non sopportavo più la tristezza e l’ho chiamato, come stai Alberto? E lui mi ha risposto sono al laghetto Cocioc, ci sto qua davanti. Ma, anche se i bambini che giocavano là fuori facevano baccano come uno stormo di passeri, dentro in casa c’era silenzio e un dito di polvere depositata sui mobili, come nelle case disabitate – per cui, dopo un quarto d’ora, l’ho richiamato, come va Alberto?
Mi sto facendo una birra e guardo i ragazzi che giocano alle slot – e gli ho detto su, dài, Alberto torna a casa che mi annoio a star da solo.
In quei giorni nessuno ma proprio nessuno mi ha chiamato per chiedermi come stavo di salute, e lui, dopo aver tentato alcune volte di parlare con suo cugino, ci ha rinunciato perché quello non gli rispondeva mai al cellulare. Siamo vissuti come sospesi in una bolla insonorizzata e, per riempiere il vuoto, gli ho raccontato della mia infanzia, di quando andavo con mio padre a pescare nel Delta, come la numerosa famiglia lo picchiava con una scopa quando si ubriacava, come facevo il bucato e giocavo a campana con le ragazze perché non c’erano ragazzi nel vicinato, non so quanto gli interessassero queste storie, magari per niente, ma almeno stava ad ascoltarmi.
Lui mi ha raccontato come si è rotto il setto nasale a 11 anni quando praticava il pugilato alla Dinamo, e come a 14 anni si è scassato la schiena quando di giorno lavorava per un tizio che gli faceva trasportare sacchi di farina. Che a 11 anni suo padre è stato lasciato da sua madre perché dopo che è uscito di galera, quando era sbronzo la riempiva di botte e la sfregiava con un coltello; e io mi sono meravigliato e come mai Alberto? E lui ha detto mio padre era dentro e mia madre poverina che poteva fare? Non le bastavano i soldi con quattro figli da tirare su per cui si è messa con uno zio mio e hanno messo al mondo un altro fratellino; e io mi sono meravigliato come mai Alberto? E lui ha detto mia madre era una donna bellissima e all’epoca era vietato abortire sennò ti spedivano in galera; e io mi sono meravigliato e ho domandato quanto bella era Alberto? – e lui ha detto tantissimo, non per niente la chiamavano Bambola.
Sono stati giorni belli e molti tristi come attraversati da una fredda corrente sotterranea, avevo la faccia sempre mogia, smorta come la vite colpita dalla filossera – e lui per mettere un po’ di allegria faceva quel che poteva: mi mostrava il cazzo o metteva la musica a palla e mi ballava intorno, canticchiando – e questo m’intristiva ancor di più, mi faceva riflettere che eravamo tutti e due dei sony boys; i sony boys sono i figli cresciuti da madri depresse i cui figli tentano disperatamente di renderle allegre; per cancellare quel loro sguardo assente, fanno capriole e scherzi o smorfie simpatiche, insomma, quello che si possono inventare per far sorridere le loro mamme; ma dentro s’incupiscono per la tristezza, si avviliscono, e allenati fin da piccoli a escogitare questi stratagemmi, da grandi diventano artisti, truffatori o distributori d’amore.
Alberto era un distributore d’amore, mi circondava di Attenzioni Cuoricini e Parole Dolci, come io avevo fatto con lui promettendogli Lavoro Carta d’Identità e Casa – ma tutto ciò non mi sollevava più il morale. Lui diceva ti amo, scemo, e io rispondevo anch’io Alberto, ma con questo non ricaviamo i soldi per vivere; lui diceva mi sei piaciuto fin dal primo momento che ti ho visto al bar di Zeicani, e io – anche a me sei piaciuto, ma ora siamo al verde; lui diceva vengo con te in campagna, dove vuoi tu, l’importante però è che stiamo insieme, e io – non abbiamo soldi per trasferirci in campagna; e allora lui diceva vengo con te a casa dei tuoi, e io – lì tu non ci puoi proprio stare, i miei ti sguinzaglierebbero contro i cani e la polizia.
Poi andava in salotto a vedere la tv – ma quando la tristezza diventava insopportabile, ritornava in camera dove io con aria assente perdevo il tempo su facebook, e si stendeva sul letto, dicendo che aveva la schiena a pezzi, fammi un massaggio; oppure, se non veniva lui, andavo io in salotto e mi stendevo sul divano e affondavo la faccia nella pelle dei suoi fianchi.
E pensavo malinconico che si era creata un’intimità, fra noi; non so se poteva essere definito amore, non ho termini di paragone se non nei libri e nei film – ma di sicuro si trattava di intimità e, in mancanza di un paragone ancorato nella carne della mia vita, questo mi bastava.
Perché le mie storie sono state rare e disastrose; mi piaceva un tipo, Andrei, ma ero io a non piacere a lui; poi, cinque anni dopo, c’è stato quel pischello che non aveva niente a che spartire con i ragazzi; lo vedevo una o due volte al mese quando con una scusa poteva allontanarsi da casa, e io avevo soldi per invitarlo a Bucarest e offrirgli qualcosa – ma ogni sua visita era per me una mazzata in testa: non gli andava di essere toccato, né di essere tenuto in braccio, e questa cosa mi gettava in un terribile stato di astinenza affettiva che il sesso non poteva temperare in nessun modo; i periodi di ferie erano insopportabili, tanto che alla fine mi impasticcavo per poterli superare. Una sola persona si è innamorata di me, Ana – ma era del sesso sbagliato.
All’inizio c’erano stati solo sesso e baci meccanici, perché, dopo avermi fottuto, si girava di spalle – I mean io lo abbracciavo e gli accarezzavo il petto e la pancia, e lui mi prendeva la mano e diceva non accarezzarmi più oppure ho caldo, fatti in là; poi ha iniziato a stare da me e, quando non lo abbracciavo più, mi si spingeva contro con il sedere o tentava goffamente di accarezzarmi e di succhiarmi i capezzoli – perché così faceva quando aveva bisogno di qualcosa, per farmi capire che voleva un massaggio, si metteva a torcermi la schiena e le gambe; poi ha cominciato a dormire con la faccia rivolta verso la mia, naso contro naso – e quando ha fatto questo, l’ho interpretato come un passo in avanti, perché nei tre anni che è durata la relazione con Ana non ero mai riuscito a dormire in quel modo con lei, potevo solo tenerla abbracciata come si fa con i bambini, di spalle.
E, mentre se ne stava con le mani sotto la testa sul letto sfondato, mi raccontava dei cani di Borcan, due maschi di grossa taglia, un rottweiler e un pastore tedesco – li aveva allevati fin da cuccioli, mangiavano solo dalla sua mano e ubbidivano solo a lui, mentre sbranavano chi osava entrare in cortile, erano i miei soldati, si ricordava, così e mi posava in grembo la sua testa – e gli ero così affezionato che di notte dormivano con me a letto.
E io dal computer gli dicevo: è inutile che giudichi Borcan, quello ti ha voluto bene, ti ha tolto dalla strada, senza di lui ora ti ritrovavi in stazione o, Dio te ne scampi, in galera; e lui rispondeva, già, ha fatto quello che papà non ha fatto con me, e io completavo hai fatto la bella vita là dentro, stavi in famiglia, la casa era al completo, come dicevi quando arrivava la sua cognata dall’Italia? Liliana l’Altolocata? – e lui si piegava in due dalle risate e diceva sì, e io ripetevo, Liliana l’Altolocata, e si sbellicava, Liliana…
Ecco, vedi Alberto, aggiungevo io, è per questo che mi dispiace, perché ti ho separato dalla tua famiglia e, ecco, ora non possiamo andare da nessuna parte e stiamo chiusi qua fra quattro mura, questa non è vita Alberto; e lui scuoteva tristemente la testa non è vita questa, no, sembra di stare in prigione.
E quando mi sono alzato dal computer e gli ho detto senza mezze parole chiama Borcan, amico, ti perdonerà perché è sangue del tuo sangue, e lui ha detto non lo chiamo manco morto, è con te che voglio fare la mia vita.
E ha aggiunto: non posso più staccarmi da te, ho imparato a lasciarmi abbracciare da te e lasciarmi passare la mano sul petto, tutti si sono presi gioco di me tranne te e la mia vecchia; sono stato a puttane, ma quelle non mi abbracciavano, sono finito in galera, ma lì mi fottevano e al posto di una buona parola sbang un cazzotto in testa quando gli andava qualcosa.
E che può dire uno ancora dopo aver sentito questo?
Poi sono finiti anche gli ultimi soldi e ho detto che facciamo Alberto, io mi fumo le rollate che tu non puoi soffrire; e lui ha risposto ce la caveremo, su, vieni con me a fare un giro – e abbiamo camminato così per un bel po’ di ore elemosinando sigarette. Se ne è procurate circa sei, che ci siamo fumate a Cocioc, dove siamo andati per sederci davanti al laghetto. Mentre ci dava dentro con le sigarette per togliere con i denti il filtro, per poi steccarcele come fanno i carcerati, ha detto non voglio stare da Borcan, fratellino, mi sono stufato di dormire in compagnia dei cani, voglio anch’io qualcuno che mi tiene fra le braccia, avere qualcuno con cui parlare di qualcosa.
E che può dire uno ancora dopo aver sentito questo?
(…)
A cura e traduzione di Mauro Barindi
(n. 3, marzo 2014, anno IV)
|
|